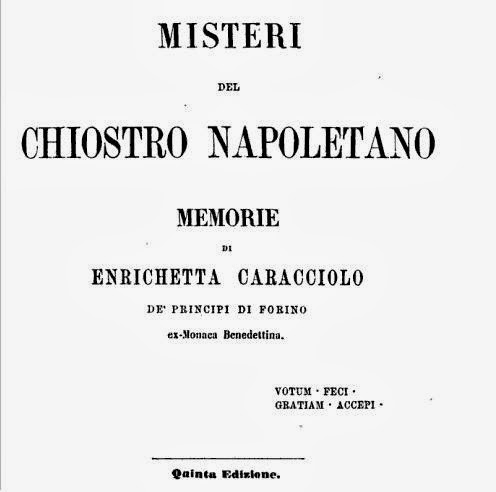Almanacco del 17 Febbraio:
 |
| La Signora di Monza, Giuseppe Molteni, 1847, Musei Civici di Pavia. |
Enrichetta Caracciolo nasce
oggi 17 Febbraio 1821, una vita straordinaria che pare un romanzo, uno di
quelli scritti da qualche sua contemporanea per denunciare ed esemplificare la
condizione femminile e che invece non prende spunto da un’emblematica vita esemplificativa
ma è biografia, storia di vita vissuta sulla pelle, come quella di tante
eroine, e parola non fu mai più adatta se non per lei.
Nasce a Napoli da don Fabio
Caracciolo, figlio del Principe di Forino, maresciallo dell’esercito
napoletano, e dalla nobildonna Teresa Cutelli, in una “delle prime e più cospicue
famiglie di Napoli” e vive un’esistenza
abbastanza tranquilla tra Bari, Napoli e Reggio Calabria, a parte una parentesi
di qualche anno che li vede caduti in disgrazia per la perdita del lavoro del
padre, quando l’amato padre muore per un’infezione agli organi interni. A
fronte della volontà di sua madre di risposarsi, c’è l’inganno materno che vede
Enrichetta avviata, a sua insaputa, in convento. Si attua quello che una monaca
“forzata” di qualche secolo prima, la Tarabotti, identifica come il tradimento più
grande, quello dei propri genitori.
Enrichetta cerca riparo dalla decisione
materna disperandosi e piangendo così che la madre le promette che starà in
convento solo pochi mesi per poi riprenderla in casa.
Enrichetta così si ritrova
destinata, come nella “migliore” tradizione al convento dove già erano
presenti delle sue zie paterne, a Napoli al Convento di San Gregorio Armeno, di
tradizione benedettina, poiché: “(...) mi dava il nome di Enrichetta, nome di
una monaca zia paterna: una delle innumerabili offerte, che all’ordine di San Benedetto,
consacrò la mia stirpe”.
Enrichetta subisce quello che
nella società era abitudine consumata sulla pelle delle donne, le sue sorelle
maggiori infatti saranno maritate ma lei, con due amori andati male e senza
dote dopo la morte del padre, sarà l’unica a subire, quinta di sette figlie,
una monacazione forzata, perfino Giuseppina malforme, ormai zoppa dopo una
rovinosa caduta troverà da sposarsi.
Enrichetta sarà vittima di una
prassi in teoria già condannata dalla Controriforma del cinquecento ma che non
aveva in realtà avuto alcun effetto sulla consuetudine ben più consolidata
nella cultura della società pre- italica e che anzi metteva in risalto un mal
costume diffuso e condiviso, unitario ancor prima che si formi la nazione.
TUTTI I CONTENUTI DEI POST SONO SOTTO COPYRIGHT
Enrichetta dunque però almeno inizialmente
riesce ad uscire dal convento, decisa a non prendere i voti nonostante le
insistenze di tutte le altre monache, nonché della badessa sua zia, dei prelati
e dei confessori e si rifugia a casa di un cognato dove viene a sapere dalle
sorelle maggiori, sposatesi a Reggio, che la loro madre sta per risposarsi
proprio a Reggio e vuole condurla lì per farla entrare in un convento in
Calabria, e che anche il suo fidanzato ormai si è messo l’anima in pace e
corteggia un’altra. Enrichetta a questo punto, trovatasi sola, senza appoggi e
senza un posto dove andare, raggiunta dai gendarmi che l’accusano di insubordinazione
ai voleri della madre, e che vogliono portarla all’imbarco per Reggio e farle raggiungere
così sua madre, è quindi costretta a tornare in convento e prendere i voti: “Il
mio sacrificio da quel momento era consumato: mi considerai una vittima”.
Così nel 1841 Enrichetta prende
i voti definitivi e si ritrova monaca suo malgrado ma se “avevo fatto alla
comunità il sacrificio della mia persona ma non già quello della mia ragione,
che è un diritto inalienabile” ormai “Morto il passato,
estinto l’avvenire per me; le memorie un vano sogno: le speranze un delitto” , “Non doveva più avere né
madre, né sorelle, né parenti, né amici, né sostanza alcuna;
aveva abdicata perfino la mia personalità”.
 |
| La Monaca di Monza, Mosé Bianchi, 1867 , Musei Civici di Monza. |
Il primo impatto in convento fu
dei peggiori, ritrovandosi a vivere, in clausura, lei, colta e amante delle
arti e della letteratura, in un ambiente fatto da monache rozze, incolte, semi
analfabete “la più parte giovani, o almeno non vecchie, e tutte, siccome dissi,
appartenenti alle più cospicui, se non sempre alle più ricche, famiglie dell’ex
capitale.
Ebbi però l’occasione d’osservare, fin
dal primo giorno del mio ingresso al convento, che le condizioni intellettuali
e morali di quelle suore non rispondevano punto all’elevatezza de’ loro natali”.
La sua esistenza come detto
sembra un romanzo e così anche Enrichetta, come ogni eroina che si rispetti,
ebbe il suo cattivo: l’arcivescovo di Napoli, Riario Sforza, a cui dedicherà un
intero capitolo, il XVII , delle sue Memorie.
TUTTI I CONTENUTI DEI POST SONO SOTTO COPYRIGHT
Con l’elezione di Papa Pio IX,
Enrichetta pensa di avere un barlume di speranza nel risolvere la sua
condizione chiedendo clemenza direttamente al Pontefice che non sembrò affatto
contrario alle sue richieste se non che l’arcivescovo di Napoli, Riario Sforza
non volle rilasciare il nullaosta che avrebbe potuto consentire ad Enrichetta
di intraprendere una nuova vita, contravvenendo anche alle preferenze papali.
Durante i moti del ’48 Enricchetta
riprende animo e incurante della fama che le viene riservata legge, anche a voce alta, nel convento
i giornali “rivoluzionari” meritando l’accusa di essere coinvolta in società
segrete, rivoluzionarie. Forte delle scosse che la società stava vivendo torna
ad appellarsi al Papa per la sua libertà, informandolo che altrimenti avrebbe
approfittato della libertà di stampa per far conoscere la sua condizione di
monaca forzata che interessava anche tante altre donne. Così questo l’autorizza
a recarsi in un conservatorio, di Costantinopoli, ma l’ arcivescovo Sforza, sentitosi sconfitto
la obbliga a lasciare al convento i beni di famiglia, i preziosi e l’argenteria.
Arrivata al Conservatorio di Costantinopoli, però la monaca trova un ambiente tutt’altro
che aperto e conciliante e in cui dovette abbandonare ogni speranza di poter
coltivare le sue letture e si dovette concentrare allora esclusivamente sulle
biografie delle santi e martiri della Chiesa, scoprendo quanto le figure
femminili avevano contribuito, rivelandosi fondamentali ma non per questo
valutate e riconosciute.
 |
| Immagine di Enrichetta Caracciolo nella copertina delle sue Memorie |
Nel frattempo, lo Sforza
continua la sua lotta contro Enrichetta e riusce ad intercettarne alcuni
scritti che essa faceva uscire dal Conservatorio con la compiacenza
di una governante. Questi scritti furono portati al Papa per convincerlo a non
cedere alle richieste strazianti di Enrichetta e della sua madre, divorziatasi
nel frattempo dal secondo marito e ormai pentita dell’ingiustizia.
Solo nel 1849 Enrichetta riesce
finalmente ad uscire dal conservatorio per essere curata ai nervi, in compagnia
della madre ma il nullaosta le viene negato l’anno successivo per volontà del
Vicario di Napoli, Riario Sforza.
A questo punto anche la madre
di Enrichetta, Teresa, si applicò per “salvare” la figlia facendola evadere e rifugiare a Capua sotto la
protezione del vescovo che però morì solo
pochi giorni dopo ma con l’ aiuto di un
amico sacerdote, Enrichetta ebbe il permesso di andare ad abitare con la madre
dovendo però seguire la regola della Canonichesse di Sant’Anna, e riuscì anche a farsi restituire la rendita della sua dote monacale che Riario Sforza
le aveva sequestrato, facendola vivere esclusivamente grazie al sostentamento e
all’aiuto parentale.
TUTTI I CONTENUTI DEI POST SONO SOTTO COPYRIGHT
Nel 1851, lo stesso arcivescovo, forte della
sua influenza su Ferdinando II, la fa arrestare e condurre alla Chiesa di Santa
Maria delle Grazie a Mondragone dove Enrichetta tentò il suicidio, dapprima
rifiutando il cibo, e poi pugnalandosi in petto. Ormai debole per la carenza di
nutrizione però la sua ferita risultò lieve e non tale da portarla a morte,
così sopravvisse e per un intero anno resistette alla clausura più totale,
quando però le fu impedito anche di recarsi al capezzale della madre morente,
aiutata dai parenti e dalle zie si rivolse ancora una volta alla curia per
chiedere aiuto, si appellò alla Sacra Congregazione per avere il permesso di
recarsi ai Bagni di Castellamare per curarsi la salute, questa volta
ottenendolo, infatti ormai anche la curia era infastidita dalla persecuzione, a
questo punto palese e personale, del Riario nei confronti della Caracciolo e
trovò un equivoco di fondo nella lettera dell’arcivescovo per acconsentire alle
cure.
Da qui Enrichetta trovò una
nuova vita: “Il 4 Novembre del 1854, dopo tre anni e quattro mesi di crudele
prigionia, rividi la luce del giorno”.
Rientrata in incognito a
Napoli, per aiutare la causa del paese Italia: “Che faceva intanto io inoperosa
in Castellamare? [...] pensando dunque che si sarebbe in Napoli ritrovato un
piccolo posto anche per la mia personale operosità, pensai di mettere in non
cale ogni pericolo, purché potessi prestare anch’io qualche tenuissimo servigio
al movimento che s’ordinava”, si diede, come si dice,
alla macchia, cambiando abitazione e personale di servizio come si cambia
tovaglia per sfuggire alle spie dei Borboni e del suo acerrimo e storico nemico
che l’aspettava per la resa dei conti, l’arcivescovo Sforza.
Ormai era davvero in contatto
con i liberali, con i padri della nazione unita così nel 1860, durante la messa
del Te Deum per festeggiare la fuga del re Francesco II delle Due Sicilie, in
presenza di Garibaldi “[...] Io toltami il velo nero dal capo, e ripostolo sur
un altare, ne feci atto di restituzione alla Chiesa, che me la aveva dato vent’anni
fa. VOTUM FECI, GRATIAM ACCEPI”.
Cominciò così una nuova vita
per Enrichetta, la sua vita, non meno avventurosa ed affascinante.
Si sposa con Giovanni Greuther,
scegliendo il rito protestante dopo la negazione della chiesa cattolica, e
comincia a raccontare, grazie alla stampa la sua straordinaria esistenza
scalfita dalla monacazione.
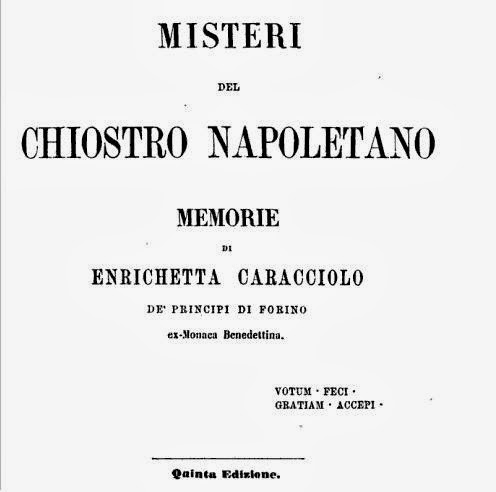 |
| La prima opera di Enrichetta Caracciolo, le sue Memorie. |
Nel 1864 sarà la volta della
sua prima opera, le sue memorie che furono tradotte in ben sei lingue, inglese,
francese, tedesco, spagnolo, ungherese e greco ed ebbero un successo strepitoso
anche in patria con ben otto ristampe, che le valsero anche le lodi di Manzoni
e di Garibaldi.
Di due anni dopo, del 1866, è
la sua seconda opera “Un delitto impunito: fatto storico del 1838” in cui narra
l’omicidio di una educanda da parte del prete che era stato respinto da quest’ultima.
Scrisse poi negli anni “I
miracoli” del 1874, raccolta di poesie contro la superstizione, e il dramma “La
Forza dell’Onore” che venne anche rappresentato e nel 1883, tratto dalle sue
memorie, fu edito un dramma in cinque atti “Un episodio dei Misteri del
Chiostro napoletano”; numerosi furono anche gli articoli che scrisse, come
corrispondente, per i giornali “La tribuna” di Salerno, “La rivista partenopea”
e “Il Nomade” di Palermo.
TUTTI I CONTENUTI DEI POST SONO SOTTO COPYRIGHT
Fu membro di spicco di numerose
associazioni tra cui Il Vessillo della carità, l’Associazione della gioventù
studiosa di Napoli, la Società per l’Emancipazione della Donna di Lorino, tanto
che nel 1866 in occasione dei moti della III guerra d’indipendenza si appellò
direttamente alle donne, alla loro forza, pubblicando il “Proclama alla Donna Italiana”
per mobilitare le donne alla causa nazionale.
E ampio e incondizionato sarà il
suo impegno politico, appoggiando, tramite il Comitato femminile napoletano di
cui, con la sorella Giulia Cigola, faceva parte, il disegno di legge di
Salvatore Morelli del 1867 “Per la reintegrazione giuridica della donna” in cui
Morelli chiedeva la partecipazione al voto amministrativo e politico delle
donne, un disegno di legge che però non fu neanche ammesso alla lettura.
Ma come si registra speso nella
storia personale delle donne, che come sappiamo purtroppo risulta cosa altra
dalla Storia, Enrichetta nonostante si fosse mobilitata e spesa per la causa
unitaria non ricevette alcuna riconoscenza, infatti Garibaldi lasciò Napoli,
per andare a Capri, prima di firmare il decreto con cui avrebbe voluto nominare
Enrichetta ispettrice degli educandati di Napoli e anche il ministro dell’istruzione
De Sanctis che pure le aveva promesso un incarico , la rinnegò.
Così Enrichetta visse gli
ultimi anni della sua vita nella sua città, ormai vedova e senza gli averi di
famiglia che l’arcivescovo le aveva sequestrato e che non si trovarono mai più,
dimenticata dal suo popolo ma almeno finalmente libera. Noi invece la
ricordiamo, e ci piace ricordarla, come lei preferiva: “[...] E il nome di cittadina, che dato a tutti non contiene
alcuna distinzione, divenne per me il titolo più proprio[...]. [...] perciò
chiamatemi Cittadina, e se volete
aggiungere una distinzione dite: quella cittadina che provocò e promosse il Plebiscito
delle donne in Napoli”.
E a Napoli, nella sua città, morirà il 17 marzo
1901, a 80 anni.
TUTTI I CONTENUTI DEI POST SONO SOTTO COPYRIGHT
Opere:
“Misteri del chiostro napoletano”, 1864;
“Un
delitto impunito: fatto storico del 1838”, 1866;
“Proclama
alle Donne d'Italia”, 1866;
“ I
miracoli”, 1874;
“La forza dell'onore”,
dramma;
“Un episodio dei misteri del Chiostro
Napolitano: dramma in 5 atti di Enrichetta Caracciolo Forino ex monaca
benedettina”, 1883.
Biografia:
¨ Caracciolo Enrichetta, “Misteri del Chiostro napoletano”, con
Nota critica, prefazione di Maria Rosa Cutrufelli, Firenze, Ed. Giunti, 1998.
¨ Sciarelli Francesco, “Enrichetta Caracciolodei principi di Forino,
ex monaca benedettina. Ricordi e documenti”, Ed. Pisano, 2013.
¨ Caracciolo Enrichetta, “Misteri del Chiostro napoletano”, ed. Barbera, 2013.
TUTTI I CONTENUTI DEI POST SONO SOTTO COPYRIGHT
Opere di dominio pubblico: